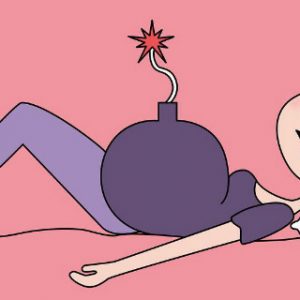Dal 1981, il 3 dicembre si celebra la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità. E’ stata indetta dall’Onu per promuovere i diritti e il benessere dei disabili. Nonostante i suoi quasi 40 anni, c’è ancora molto da fare per migliorare la situazione dei disabili in Italia.
Per riflettere sull’argomento in questa giornata, abbiamo intervistato una mamma che ha tre figli, di cui non uno, ma due con disabilità motorie comparse nella prima infanzia. “Alla nascita entrambi erano normali, poi poco alla volta sono comparsi piccoli segni che sommati hanno configurato il quadro di una tetraparesi con disartria e disfagia, e per fortuna una quadro cognitivo integro. Neppure ora abbiamo la diagnosi: si tratta di una patologia genetica molto rara, ancora sconosciuta. Probabilmente sono un caso unico al mondo. Le indagini genetiche sono ancora in corso.”
Nel frattempo, una delle sue principali preoccupazioni è assicurare la loro inclusione nella società: “Vorrei che ci fosse più sensibilità e più reale inclusione. Non pietismo. Inclusione vera da parte di tutti, specie dai coetanei e dalle loro famiglie.”
Secondo i dati più recenti dell’Istat, nell’anno scolastico 2016-2017 gli alunni con disabilità erano pari a 90 mila nella scuola primaria (pari al 3% del totale degli iscritti) e 69 mila nella scuola secondaria di I grado (il 4% del totale). Complessivamente, circa 3 mila in più rispetto all’anno precedente.
A Torino dal 1993, la Fondazione Paideia Onlus offre sostegno e supporto alle famiglie con figli disabili. Parallelamente, l’Associazione Amici di Paideia onlus promuove diverse attività per favorire le occasioni di convivio, divertimento e svago, oltre ad organizzare soggiorni estivi per le famiglie, seguendo lo stesso modello della Fondazione.
Un avvenimento inaspettato
Avere un figlio disabile non è qualcosa che si spera o si programma. È un avvenimento che capovolge completamente la vita di una famiglia. Per quanto possa essere vissuta in modo positivo, il rovescio della medaglia c’è sempre. E l’atteggiamento migliore è cercare i servizi specializzati il prima possibile. A raccontarlo una mamma, una vera supereroina, che ha preferito l’anonimato.
Cosa cambia nella vita di una famiglia con un figlio disabile?
Assolutamente tutto. Perché quella che è la cosiddetta normalità di una qualunque famiglia non esiste più, tutto ruota intorno alle loro necessità, qualunque esse siano. Mi riferisco al tipo di disabilità. Nel mio caso, sono disabilità motorie. Devi adattare le tue attività e i tuoi ritmi a loro. Per esempio, uscire di casa. Per fortuna abitiamo in una casa accessibile, di nuova concezione, ma andare in un posto dove ci sono tanti gradini o altre barriere particolari costa fatica. Non hai più quella leggerezza di dire: “Ragazzi, usciamo!”, e i tuoi figli che si preparano, si vestono, vanno in bagno e partono. Tutto dipende da te, fisicamente.
C’è un senso di pesantezza, perché non hai la libertà di fare quello che a volte vorresti fare. Per esempio: non hai voglia di portarlo in bagno o di mettergli il pigiama? Devi farlo lo stesso. Fuori piove ma devi uscire: ti munisci di carrozzina, parapioggia, mantelle, tutto quanto necessario per loro e nel frattempo tu ti bagni. Compri un mezzo attrezzato per caricare due carrozzine elettroniche. Perdi la condivisione con gli amici, che a un certo punto si autoselezionano, perché per condividere la disabilità ci vuole anche una certa sensibilità, sia da parte dei genitori che dei figli. Ci vuole un’educazione da parte delle famiglie nei confronti dei figli, per imparare a voler vedere che, al di là di una disabilità, ci sono sempre una persona e una famiglia dietro.
Cambiano le tue priorità. Cambia il progetto di vita. Nelle prime fasi c’è l’angoscia di voler capire che cosa sta capitando. Per noi ancora più complicato perché non abbiamo la diagnosi, non abbiamo neanche una prognosi di quello che sarà. Viviamo quotidianamente quello che c’è e immaginiamo quello che arriverà. In questo forse facilitati – purtroppo dico – dal fatto che siamo due medici (n.r. marito e moglie). Questo ci crea ancora più angoscia, perché possiamo immaginare un futuro con più consapevolezza e non è un futuro roseo. Non perché siamo pessimisti, ma proprio perché abbiamo più coscienza di che cosa può portare la disabilità. L’enorme angoscia del “dopo di noi”: cosa sarà dei miei figli, dove saranno, chi li accudirà e soprattutto in quale modo. Questa è veramente un’angoscia infinita.
C’è l’idea di creare una rete di persone che possano amare i miei figli anche quando io e mio marito non ci saremo più, che possano avere un’attenzione e una sensibilità per quelle che saranno le loro necessità. I miei figli sono totalmente dipendenti in tutto, non potranno mai stare da soli in casa, avranno sempre bisogno di un’assistenza, e questo rende tutto molto complicato.
Cosa manca nella società per agevolare la vita di queste persone?
Nella società manca sostanzialmente tutto. I servizi dell’ASL sono insufficienti per qualità e quantità. Faccio presente che l’ASL disattende alle linee guide ministeriali per il trattamento neuroriabilitativo dei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile, cioè dell’età evolutiva; non risponde neanche ai requisiti minimi. Questo grava economicamente sulle famiglie. Credo che sia lecito sperare in cure migliori qualitativamente e quantitativamente, che possano ridurre la disabilità e quindi portare ad un adulto con delle competenze in più.
Ho accusato spesso i colleghi di non ascoltare le madri, di non ascoltarmi quando raccontavo segni e sintomi che evidenziavo a casa, ma siccome non erano evidenziabili in visita non venivamo presi in considerazione. C’è stato anche un ritardo nel riconoscimento della patologia dei miei figli perché erano situazioni particolari, ma comunque la presunzione del medico era: “se non vedo quel segno che tu mi racconti, per me non esiste”. Non fidandosi del fatto che gli interlocutori, nella fattispecie io e mio marito, eravamo più che affidabili. È una cosa che ho detto più volte: mancano l’ascolto e l’umiltà.
Viviamo in una società che non è inclusiva, assolutamente. È ancora un problema se vai in un locale e dici che hai una carrozzina. Ti guardano storto perché devono assegnarti un tavolo un po’ più grande, nel quale avrebbero messo a mangiare più persone. Invece lo danno a te, che con due carrozzine prendi più spazio di un altro.
E a scuola, cosa manca?
Manca una reale integrazione, perché l’integrazione scolastica è affidata spessissimo alla buona volontà dei singoli. Il personale del sostegno è altamente insufficiente e molto spesso inadeguato, perché i docenti di sostegno realmente formati per questo sono pochissimi, e quindi vengono messe persone che lo usano come un ripiego, senza averne le capacità reali. E questo si vede nel quotidiano, lo abbiamo purtroppo vissuto più volte negli anni.
Mi piacerebbe che i miei figli fossero più coinvolti dai compagni, avessero più amicizie. Nella realtà ogni famiglia è molto egocentrica, perché è più facile rimanere centrati sulle proprie esigenze, sui propri ritmi: ad esempio, è più facile invitare o organizzare attività con amichetti che camminano, piuttosto che coinvolgere anche chi ha delle difficoltà. È più facile lasciare a casa chi ha una disabilità. È più facile uscire con chi ti viene a chiamare sotto casa, e via. Questo porta nel tempo a un isolamento del disabile, che patisce. I miei figli non hanno alcuna compromissione cognitiva, e io vedo che specialmente la più grande soffre molto il fatto di essere esclusa dai compagni. Lei si vergogna e si rifiuta di comunicare a scuola, e questo non la aiuta. Con noi e fuori dalla scuola parla, ma a scuola non lo fa.
Tutto questo crea isolamento, frustrazione, rabbia, demotivazione anche sul versante scolastico, perché dicono “cosa studio a fare, a cosa mi serve?”. Ho cercato di creare una rete fin da quando erano piccini, in modo che questa rete reggesse da adulti, e non mi è riuscito. Le persone con cui l’ho creata, belle famiglie con bei figli, cresciuti insieme ai miei, poi si sono trasferite fuori Torino, e la distanza non ha aiutato. Se non si coltivano certe abitudini, inevitabilmente, non se ne esce. È triste, ma è reale, a me dispiace molto.
Spero almeno che per mio figlio più piccolo questo si verifichi in misura inferiore, che i bambini e le famiglie vengano sensibilizzati di più a stargli vicino. È un bambino come gli altri, vuole giocare e divertirsi come tutti e vuole stare con i compagni. Poi come tutti ha i suoi gusti e ci saranno i compagni e compagne che gli sono più simpatici, ma questo mi sembra assolutamente normale e condivisibile.

Cosa diresti a una famiglia che ha appena avuto un figlio disabile?
Direi di fare rete il più possibile con persone che sostengano (n.r. la disabilità), perché ci si ritrova veramente infinitamente soli. E di attivare i servizi di supporto e sostegno alla famiglia. Una grande parte delle famiglie in cui arriva un figlio disabile si separa, perché la fatica e il peso diventano veramente eccessivi. Noi non siamo diversi dagli altri. Tanti periodi di difficoltà rispetto alle tensioni che si vengono a creare in casa sicuramente li abbiamo vissuti anche noi.
Né io né mio marito siamo di Torino, siamo venuti per lavoro anni fa. Abbiamo una rete famigliare molto scarna, a parte mia mamma, santa donna che ha scelto di trasferirsi qui dopo la nascita del mio terzo figlio per aiutarci e sostenerci ulteriormente. Alla fine siamo soli in una città in cui viviamo ormai da tanti anni, ma non abbiamo una rete familiare. Che poi non è detto che ti sostenga, perché anche quando c’è, alcuni componenti si chiamano fuori.
A quali servizi vi siete rivolti?
Per noi è stata una grande scoperta, anche di bellissime persone, la Fondazione Paideia, che ho scoperto anche tardi. Mi è stata segnalata casualmente da una persona che lavora con me che, a sua volta, ha un figlio disabile. Non c’è una corretta informazione dell’esistenza di servizi a cui si può accedere. Questo non vuol dire che tutti abbiano diritto a tutto, ma almeno l’informazione rispetto alla loro esistenza credo sia dovuta. Verranno valutati, insieme alle varie persone della rete (neuropsichiatra, assistente sociale, fisioterapista, psicomotricista), quali sono i bisogni e le necessità della famiglia, per attivare i servizi più appropriati.
Quando andavo per esempio dalla neuropsichiatra o dalla psicologa dell’ASL, dicendo “ho scoperto che c’è questo servizio”, ogni volta mi sentivo dire “ah sì certo, noi attiviamo anche questo”. E chiedevo perché non ce l’avessero ancora detto, sapendo che eravamo sott’acqua… Dopo la seconda diagnosi soprattutto! Se già la prima ti sconvolge la vita, la seconda ci ha colpiti e affondati del tutto. Il fatto che avessimo un buon grado d’istruzione li ha fatti sentire al riparo dal pensare che potessimo avere bisogno di aiuto. Ma la disabilità non guarda l’istruzione delle famiglie che va a colpire, non guarda in faccia nessuno. Il dolore, la sofferenza, lo smarrimento, la fatica sono uguali per tutti. Anzi, per noi che siamo due medici è anche peggio: vediamo segni e sintomi di cose non belle che si stanno già avvicinando alla finestra.
Voi avete due figli disabili. Quali sono le difficoltà più dure da gestire?
La lista è infinita. Da quelle proprio fisiche e materiali: il mal di schiena, perché sollevare, lavare, vestire, è faticoso. È faticoso emotivamente vedere mia figlia che piange perché non riesce a uscire con i compagni, perché non la coinvolgono. È faticoso vedere mio figlio frustrato perché non riesce a parlare e non riusciamo a capire cosa ci vuole dire. A quel punto lui si offende e si rifiuta di scrivere, che è la modalità che purtroppo sempre più spesso utilizziamo per comunicare. La rinuncia a comunicare un bisogno, un desiderio, un piacere, una qualunque cosa da parte dei miei figli, per me è una sconfitta enorme. D’altra parte se non riusciamo a capire, non è cattiva volontà, è che non c’è modo di comprendere, e così rimane l’unico canale quello della scrittura. Vedere la chiusura dei miei figli è sofferenza.
Quali invece gli ambienti in cui avete più supporto e solidarietà?
La Fondazione Paideia, sostanzialmente. Belle persone, bel gruppo, belle famiglie.
E alcune persone della rete intorno a noi: la storica fisioterapista di mia figlia, persona davvero meravigliosa, che ci segue da tanti anni e nella sua vita è veramente una colona portante.
E un medico speciale, dotato di grandissima umanità e professionalità. Nonostante abbia sbagliato la diagnosi (come peraltro è successo a tutti quelli che hanno visitato i miei figli), quando si è trattato di condividere la diagnosi di disabilità di mio figlio, il terzogenito, è stato l’unico che ci ha chiesto scusa per l’errore diagnostico commesso. Abbiamo sempre apprezzato la sua umiltà e umanità: in quell’occasione un punto di riferimento in Italia, si è preso tre ore per parlare con noi, nonostante la coda fuori di altre visite prenotate, e ci ha dedicato il tempo che ha ritenuto giusto e doveroso per condividere la diagnosi. Non è poco. Chiaro che non ha guarito i miei figli, ma l’umanità che ho trovato in lui, onestamente, non ho trovato in nessun altro medico.
Avete riscontrato differenze tra nord e sud d’Italia?
Nel tempo ci sono capitate anche persone molto carine e gentili. Soprattutto una bellissima esperienza l’abbiamo avuta quando i miei figli sono stati ricoverati un mese all’ospedale Santo Bono di Napoli; credo sia stata una delle esperienze più belle umanamente, sia per il personale medico che paramedico, sia per gli operatori che per altre persone. Come la signora delle pulizie: visto che il cibo dell’ospedale oggettivamente non era buono, mi chiedeva cosa piacesse ai miei figli e come lo cucinassi, e lei quando poteva lo preparava a casa e me lo portava. Cose non scontate, non dovute, non richieste, ma di una bellezza unica.
Poi andavamo, quando ci davano il permesso, a mangiare nel fine settimana nelle varie pizzerie della zona, e abbiamo incontrato sempre persone molto gentili e affettuose. Sicuramente ho trovato più accoglienza in meridione, e più sensibilità rispetto a qui. Torino, la definirei, per lo più freddina, a tutti i livelli. Con questo forse mi andrò a inimicare tutti, ma è la mia esperienza, la realtà che abbiamo vissuto fino a oggi. È difficile trovare comunque persone sensibili e coinvolgenti.
Leggi anche: Sessualità e disabilità: uno degli ultimi tabù